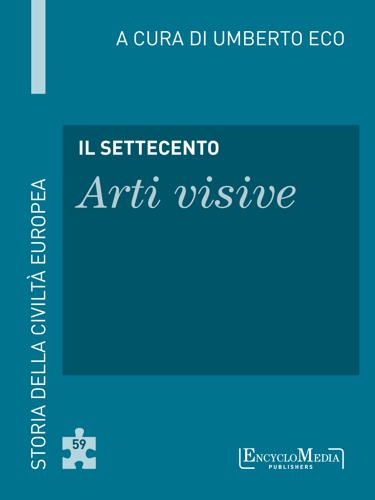La riscoperta dell’antico
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Il rapporto fra il Settecento e l’antico si apre su molti versanti, assumendo colorazioni molto diverse da quell’antico, sentimentale ed eroico, celebrato da Poussin e Rubens. Le grandi campagne di scavo intraprese e la febbre divorante delle esplorazioni archeologiche rendono la conoscenza del passato più sistematica e meno frammentaria. L’esemplarità dell’antico finisce per imporsi, verso la fine del secolo, dopo lunghe discussioni sul tema cruciale dell’imitazione.
L’ambiguità del passato
Nella prima pagina dei suoi Pensieri sull’imitazione dell’arte greca in pittura e scultura (1755) Johann Joachim Winckelmann dichiara che “l’unica via per divenire grandi e, se possibile, inimitabili, è l’imitazione degli antichi”, dando così il via a una serie inesauribile di riflessioni sul tema dell’imitazione, degli archetipi culturali prescelti, della loro declinazione al presente. E mentre, rispetto all’antico, la copia e il calco conducono alla sclerosi della creatività – con quella connotazione di pessimismo che riaffiora poi nell’età romantica –, l’imitazione lascia il margine per un intervento in grado di estrarre dall’antico inesplorate possibilità di estensione al presente.
Gli estremi di questo processo, per usare i titoli di due affascinanti ricerche, potrebbero essere da un lato l’Antichità come futuro – titolo di un volume di Rosario Assunto –, dove il passato diventa modello di rinnovamento estetico, e dall’altro lato l’antico come “fardello” con la conseguente impotenza del “cosa mai ci rimane da fare”, secondo la formula di W. Jackson Bate (Il peso del passato, 1970). Questo processo può inoltre essere esemplificato in immagini, mettendo a confronto il frontespizio del volume Lavori di architettura dell’architetto Robert Adam e il celeberrimo disegno del pittore Heinrich Füssli, La disperazione dell’artista davanti all’imponenza dei frammenti antichi. Dunque da un lato il passato come mito rassicurante e positivo, la sua autorità per potersi orientare e la sua conoscenza quale eccitante per un processo creativo moderno, ma dall’altro rovine immense e paralizzanti nell’archeologia inimitabile e sublime di un passato che lascia all’artista moderno solo spazi minimi, condizionanti.
Gli scavi a Ercolano e Pompei e la “resurrezione” del passato
Risale al 22 ottobre 1738 la folgorante ripresa a Ercolano degli scavi bloccati nel 1711, mentre nel 1740 si dà inizio agli scavi a Pompei. Tornano così alla luce le città che erano state inghiottite dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e delle quali si era perduta perfino la memoria. La loro identificazione avviene in primo luogo attraverso le fonti letterarie e, grazie alla rilettura di Plinio il Giovane il ricordo documentario restituisce la tragedia allora inspiegabile che aveva travolto Plinio il Vecchio a Capo Miseno: “Si seppe poi in seguito che era il Vesuvio; [...] esaminano se sia preferibile starsene al coperto o andare alla ventura allo scoperto [...]; stramazzò [...], l’atmosfera troppo pregna di ceneri gli soffocò la respirazione”.
La riscoperta settecentesca di Ercolano ha un inizio del tutto casuale. Nel 1711 il principe di Elboef, facendo scavare un pozzo accanto alla propria residenza di Portici, piomba nel centro del teatro dell’antica Ercolano e recupera tre statue di vestali. Reclamate dal viceré austriaco, vengono restaurate a Roma e donate a Vienna ad Eugenio, duca di Savoia Carignano. Alla sua morte, per 600 talleri le statue passano al re di Polonia che le espone nel Giardino Reale di Dresda – fra la collezione statuaria Chigi e quella Albani appena acquistate – dove conquistano Winckelmann che decide allora di venire in Italia.
Nel 1738 re Carlo III di Borbone riprende gli scavi a Ercolano, esplorando dapprima il Teatro quasi intatto con il suo arredo di marmi e di bronzi, poi la cosiddetta Basilica. Si procede fra enormi difficoltà, per cunicoli bui a venti metri di profondità, con il rischio continuo di crolli e la necessità di strappare dal contesto i frammenti, per portarli alla superficie: la cittadina di Portici era infatti cresciuta sull’antica Ercolano, sopra una stratificazione di oltre venti metri di detriti.
Nel caso di Pompei, invece, gli scavi vengono condotti “a cielo aperto”, liberando l’intera città da lapilli e ceneri, seppure con esasperante lentezza: “per scavare una gran città come Pompei non vi trovai occupati che soli otto uomini”, afferma Winckelmann nel 1762.
I risultati dell’operazione promossa dal re di Napoli sono a dir poco scioccanti e i racconti dei viaggiatori parlano di “résurrection archéologique”, “ville romaine sortant du tombeau”. Per la prima volta il passato emerge in tutta la sua ricchezza: non solo testimonianze di architettura o scultura, ma l’intero tessuto urbanistico, la rete viaria e idraulica, il recupero sconvolgente della pittura – conosciuta fino ad allora solo attraverso rarissimi esempi, quale l’encausto delle Nozze Aldobrandini, affiorato negli scavi del primo Seicento –, gli oggetti d’uso, le arti decorative, la vita stessa fermata in un fotogramma dal sopraggiungere della catastrofe.
L’inaccessibilità degli scavi e la manipolazione dei modelli archeologici
Inizialmente la manipolazione dell’antico è quasi una prassi corrente, per la vocazione degli uomini ad assumere il passato come detonatore e come agente che spalanca sull’immaginazione, ma anche per l’inaccessibilità dei luoghi di scavo che restano affidati al ricordo e alla sua rifrazione nei disegni eseguiti furtivement et de mémoire dagli artisti. “Presentandoci al Museo [di Ercolano] ben raccomandati, non ci hanno permesso affatto di disegnare”, scrive Johann Wolfgang Goethe nel 1787.
L’atteggiamento durissimo della corte di Napoli, molto gelosa dei ritrovamenti archeologici e niente affatto incline a lasciarli copiare, nasce dal progetto politico di esibire le collezioni a testimonianza dello splendore dinastico dei Borbone. L’impresa nasce sotto il segno del privilegio reale e i reperti vengono così classificati, studiati, raccolti nel Museo Reale di Portici e pubblicati solo nell’ambito degli otto volumi de Le antichità di Ercolano esposte, edizione ufficiale della Corona. Per questo Ercolano, cui tutti tendono senza poterla davvero conoscere, diventa la proiezione di un mondo intravisto più dalla sponda del Settecento che dal versante dei ritrovamenti archeologici. Pochi vedono gli affreschi dal vero e sono quindi pochi a conoscere l’impressionismo compendiario della pittura romana e la macchia, le pennellate fluenti e materiche, il modo abbreviato e vibrante di rendere la forma.
La conoscenza di quei modelli lontani avviene solo attraverso le illustrazioni dei volumi in folio dedicati alle Antichità di Ercolano. Ma, accessibili ovunque in Europa, quelle incisioni privilegiano in assoluto la linea ed esaltano l’essenzialità del contorno, trascurando l’efflorescenza impalpabile degli encausti romani.
I reperti di scavo
Emblematico è il caso delle Danzatrici, e più esattamente del fregio con Menadi, danzatrici, centauri, ritrovato il 18 gennaio 1749 negli scavi condotti a Civita – oggi Pompei – nella villa cosiddetta di Cicerone. Celebrate da Winckelmann con poche righe memorabili, “le più belle fra tutte sono le figure delle Danzatrici su fondo nero [...] fluide quanto il pensiero e belle come se fossero fatte per mano delle Grazie”, queste figure conquistano le regioni d’Europa, imponendo dalle porcellane ai soffitti la delicata sensualità ercolanense entro una forma chiusa e tagliente, in realtà del tutto estranea al modello romano ed espressione, piuttosto, della linea funzionale tipicamente neoclassica. La trascrizione incisoria degli originali romani costituisce infatti un momento di riflessione e di rilettura dell’immagine antica: selezionare i motivi da incidere sulla matrice significa dare risalto a qualità che si ritengono caratterizzanti, innescare un processo semplificante e riduttivo.
Ha inizio allora quel processo astraente e di forte stilizzazione dell’immagine, dalla complessità della stesura pittorica al profilo purissimo dell’immagine incisa, indicato a più riprese da Robert Rosenblum (The International Style of 1800, 1956; Transformations in Late Eighteenth Century Art, 1967). Inoltre, la dinamica promossa dallo spirito stesso del razionalismo – che intende dotarsi di strumenti adatti a diffondere la conoscenza: testi teorici, tavole dei ritrovamenti archeologici, “libri di modelli”, repertori ecc. – porta in sé il germe di quella malattia che, nel XIX secolo, porterà alla consumazione accelerata di tutti gli stili e all’adorazione feticista delle civiltà del passato scorporate dalla loro funzione sociale e dalla storia, nel bisogno spasmodico di continui revival.
Ma prima che i grandi mutamenti scientifici e tecnologici sconvolgano il sistema delle relazioni con l’arte, prima che lo studio metodico dei reperti antichi faccia balenare l’idea di progettare prototipi, l’incontro con i luoghi di scavo di fine Settecento resta fissato nell’eccitazione fantastica di Giambattista Piranesi e nella grazia mozartiana di Antonio Canova. Come dimostra la serie dei disegni e delle tempere che Canova realizza nell’ultimo decennio del Settecento: una ricerca sui ritmi, le vibrazioni e gli slanci, ispirata dal ritrovamento delle famose Danzatrici. I giochi d’amore della cultura ellenistica e gli “scherzi” alessandrini conosciuti attraverso le campagne di scavo (Amorino che vola da una ninfa triste, Tre ninfe hanno rubato il turcasso di Amore, Il mercato degli amorini, Giocatrici di astragali ecc.) sono stilizzati nel disegno infallibile del grande artista neoclassico. Contro la lastra compatta del nero, che rinvia agli encausti romani da cui è tratto il soggetto, le ballerine di Antonio Canova danzano nelle loro vesti moderne di mussola à pois, scintillanti ed estrose, immuni da ogni tentazione archeologica; la falsariga, seducente e irresistibile, è quella della civiltà ercolanense, ma per Canova – così come per l’inglese John Flaxman – attraverso quel filtro esemplare passa tutta la modernità del Settecento.